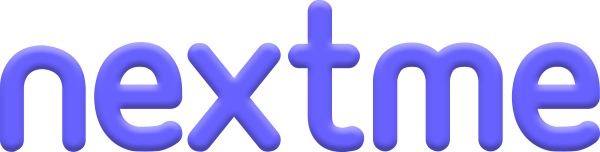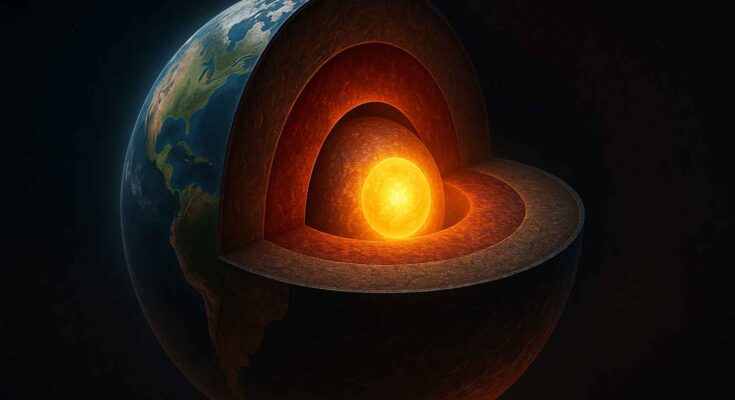Nel cuore del nostro pianeta, a una profondità superiore ai 5.000 chilometri, si trova una massa sferica solida costituita prevalentemente da ferro. Si tratta del nucleo interno terrestre, elemento cruciale per l’esistenza della vita: genera lo scudo magnetico che ci difende dalle particelle solari nocive e produce il calore che, risalendo verso la superficie, innesca il movimento delle placche tettoniche, plasmando così terre emerse e bacini oceanici.
Tuttavia, la sua composizione esatta rimane un mistero, così come la sua temperatura e il momento in cui ha iniziato il processo di raffreddamento e solidificazione. Le uniche possibilità a nostra disposizione consistono nell’analisi indiretta, attraverso le informazioni ricavate dai sismi e dalle simulazioni condotte in laboratorio.
Recentemente, una ricerca coordinata da Alfred Wilson-Spencer, esperto in fisica dei minerali presso l’Università di Leeds, ha tracciato una nuova direzione per comprendere la reale natura di questa regione profonda. E l’elemento chiave, inaspettatamente, è risultato essere il carbonio.
La struttura nucleare del nostro pianeta si articola in due sezioni: una centrale solida e una esterna fluida. La zona di transizione fra queste rappresenta il punto in cui avviene il passaggio di stato da liquido a solido. Di conseguenza, determinando la temperatura di fusione del nucleo, possiamo anche dedurre la sua costituzione materiale.
Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori utilizzano principalmente due approcci: l’analisi dei meteoriti e lo studio sismologico.
I frammenti meteoritici forniscono indicazioni sulla composizione dei corpi celesti primordiali e indicano che il nucleo dovrebbe includere ferro, nichel e probabilmente tracce di silicio o zolfo. Tuttavia, queste informazioni risultano troppo approssimative.
La sismologia, al contrario, rivela la velocità di propagazione delle onde sismiche attraverso gli strati terrestri, velocità che variano in base al materiale attraversato. Grazie a questi rilevamenti, sappiamo che il nucleo interno presenta una densità inferiore a quella del ferro allo stato puro e che il nucleo fluido è più denso della sua controparte solida, un’anomalia decisamente particolare.
Questi dati indicano che la composizione nucleare deve comprendere più componenti chimici, ma non sono sufficienti a identificarli con precisione.
La rivelazione scientifica
Per aggirare queste limitazioni, il gruppo di ricerca di Leeds ha adottato una prospettiva innovativa: il fenomeno della super-refrigerazione. Si tratta di un processo che si verifica quando un fluido si raffredda al di sotto della propria temperatura di congelamento senza cristallizzarsi immediatamente. È lo stesso meccanismo per cui l’acqua in una bottiglia può rimanere allo stato liquido anche a -5 °C, per poi ghiacciare istantaneamente quando viene scossa.
Applicando questo principio ai metalli fusi presenti nel nucleo, gli studiosi hanno constatato che il ferro nella sua forma pura necessita di un raffreddamento di almeno 1.000 °C al di sotto del punto di fusione per avviare la solidificazione. Ma questa eventualità è fisicamente insostenibile: se fosse realmente così, il nucleo interno risulterebbe molto più esteso rispetto a quanto indicano i rilevamenti sismici, oppure sarebbe completamente solidificato.
Introducendo silicio o zolfo, la situazione si complica ulteriormente: diventa necessaria una super-refrigerazione ancora maggiore.
La soluzione emerge con il carbonio: con appena il 2,4% di carbonio nella composizione nucleare, sono sufficienti circa 420 °C di super-refrigerazione per innescare la solidificazione. E con il 3,8%, ne bastano solamente 266 °C. Valori considerevoli, certamente, ma plausibili.
Il nucleo contiene più del solo ferro
Questa scoperta evidenzia per la prima volta che la presenza di carbonio rende fisicamente realizzabile la genesi del nucleo interno. E questo costituisce un avanzamento fondamentale per comprendere la vera composizione delle profondità terrestri.
Ma esiste un ulteriore elemento da valutare: i rilevamenti sismici indicano che ferro e carbonio da soli non sono sufficienti. Il nucleo deve incorporare almeno un’altra sostanza per giustificare la sua densità. Gli scienziati ipotizzano che possa trattarsi di ossigeno e possibilmente anche di silicio.
Siamo ancora distanti da una conclusione definitiva, ma questa nuova angolazione restringe il campo delle possibili combinazioni elementari e avvicina la comunità scientifica un gradino più in là verso la comprensione di ciò che si cela nelle viscere del nostro pianeta.
Fonte: The Conversation