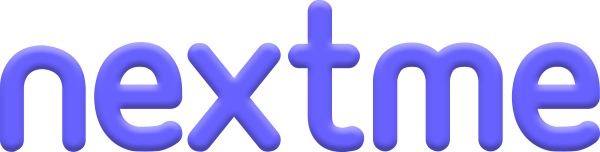Immaginate un’epoca in cui non esisteva alcuna forma di scrittura: niente registrazioni, nessuna norma trascritta, nessun metodo per tramandare le scoperte. Le conoscenze sopravvivevano solo nella mente di chi le trasmetteva oralmente, costringendo ogni nuova generazione a ripartire quasi da zero.
Questo scenario cambia radicalmente quando, circa 5.500 anni or sono, alcune popolazioni mesopotamiche cominciano a tracciare simboli su lastre d’argilla ancora morbida. Un’azione apparentemente semplice, nata da esigenze pratiche, che si rivela rivoluzionaria. Da questa innovazione emerge la tavoletta di Kish, ritenuta il più remoto reperto scritto giunto sino a noi, marcando l’inizio della documentazione storica.
Uno strumento per amministrare le risorse di un centro urbano in espansione
Il manufatto, scoperto nell’insediamento sumero di Kish e attualmente custodito presso l’Ashmolean Museum, appartiene all’ultima fase del periodo Uruk, databile attorno al 3500 a.C.. Si presenta come una placca composta da argilla e calcare, sulla quale artigiani incisero simboli mediante uno stilo, utilizzando una forma primitiva di scrittura denominata proto-cuneiforme. Questi segni pittografici raffigurano creature, derrate agricole, liquidi e operazioni della vita quotidiana.
Analizzando attentamente il reperto, gli studiosi hanno identificato simboli che sembrano documentare il processo di fabbricazione della bevanda fermentata a base di malto d’orzo, accompagnati da riferimenti a grano, capre, ovini e ulteriori pratiche agricole. Lo scopo non è narrativo, bensì gestionale: la tavoletta di Kish venne creata per annotare informazioni, monitorare le scorte e coordinare l’economia di un insediamento in forte sviluppo. Non ogni elemento è stato interpretato, e alcune porzioni restano enigmatiche, ma l’obiettivo complessivo appare chiaro.
Si tratta di un registro concepito per monitorare la resa agricola, verificare la qualità delle bevande fermentate, contare gli animali da allevamento e tracciare il flusso delle merci nei depositi. Una sorta di contabilità primitiva che preannuncia l’avvento del cuneiforme vero e proprio, il sistema di scrittura che consentirà, nei secoli successivi, di codificare norme giuridiche, narrazioni epiche, cerimonie religiose e cronache storiche.
Le raffigurazioni rupestri risalgono a periodi assai più antichi: alcune, come quella che mostra tre figure umane accanto a un suino, hanno circa 50.000 anni. Tuttavia, non assolvono la medesima funzione. Le immagini nelle caverne narrano episodi, non costituiscono sistemi di archiviazione. Non servono a quantificare, né a descrivere procedure o transazioni. Sono rappresentazioni figurative, non un codice elaborato per preservare dati specifici.
La tavoletta di Kish, al contrario, impiega simboli con uno scopo definito: illustrare l’impiego dell’orzo, spiegare la preparazione delle bevande fermentate, indicare l’importanza del bestiame e documentare i cicli agricoli che caratterizzavano l’esistenza urbana. Non è espressione artistica, ma organizzazione razionale. Testimonia come, a un determinato momento, le società urbane abbiano sentito la necessità di un metodo affidabile per ricordare ciò che rivestiva importanza cruciale.
Un reperto progettato per resistere al tempo
Dopo aver tracciato i simboli, i Sumeri permettevano all’argilla di essiccarsi e frequentemente la sottoponevano a cottura, conferendole durevolezza. Questa precauzione elementare dimostra quanto fosse fondamentale preservare tali informazioni: non dovevano dipendere dalla memoria individuale, né rischiare di scomparire con il susseguirsi delle generazioni.
Scrivere equivaleva a conferire permanenza ai dati, stabilire un riferimento comune, trasformare una serie di attività quotidiane in una memoria condivisa. Una porzione della scrittura proto-cuneiforme presente sulla tavoletta di Kish rimane tuttora parzialmente indecifrata. Appartiene a un vasto insieme di iscrizioni che gli esperti continuano a esaminare e interpretare.
Ogni nuovo simbolo compreso contribuisce alla ricostruzione dell’esistenza sumera e di quel preciso istante in cui la storia ha cessato di essere esclusivamente orale e ha cominciato a materializzarsi su una lastra d’argilla.
Fonte: University of Chicago