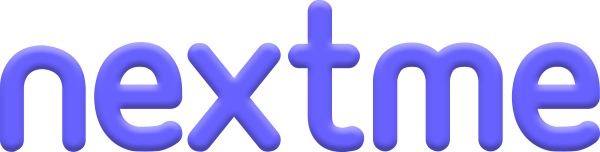Appaiono fuori luogo in una delle regioni più impervie della Terra. Eppure resistono lì da sei millenni. Disseminati sugli altopiani armeni più elevati, dove il freddo intenso permette la presenza umana solo per brevi periodi estivi, si innalzano imponenti blocchi di pietra lavorata, conosciuti come vishap o pietre del drago. Alcuni raggiungono l’altezza di un edificio a due livelli, eppure non furono mai eretti presso insediamenti, centri abitati o aree funerarie. Ed è proprio questa collocazione remota a svelarci oggi il loro autentico significato.
Per numerosi decenni gli studiosi hanno dibattuto sulla loro funzione senza giungere a conclusioni definitive. Marcatori territoriali? Elementi ornamentali? Emblemi di clan? Nessuna teoria riusciva a chiarire perché popolazioni dell’età della pietra abbiano trascinato massi di svariate tonnellate fino a oltre 2.700 metri di altitudine, in un contesto ostile e di difficile accesso. Adesso, tuttavia, una recente indagine scientifica offre una chiave di lettura completamente nuova.
Stando a una ricerca pubblicata di recente sulla rivista npj Heritage Science, i vishap armeni non avevano alcuna funzione estetica. Erano strutture cerimoniali connesse a un culto ancestrale dedicato all’acqua, risorsa vitale e venerata dalle popolazioni che abitavano e percorrevano gli altopiani caucasici durante l’epoca calcolitica.
Gli studiosi hanno esaminato 115 megaliti distribuiti sull’intero territorio montano armeno, impiegando rilevazioni GPS, analisi altimetriche, misurazioni precise e datazioni al radiocarbonio. È emerso un elemento notevole: questi monoliti si ergono quasi invariabilmente in prossimità di fonti naturali, corsi d’acqua alimentati dal disgelo, bacini d’alta quota, crateri vulcanici o antichi sistemi di canalizzazione preistorici. L’acqua, in quegli ambienti estremi, non rappresentava solo un bisogno primario. Era esistenza, e in quanto tale veniva adorata.
Pilastri lavorati per ergersi, non per essere contemplati
Esaminandoli attentamente, i vishap mostrano un particolare costante che finora era stato trascurato. Tutti presentano superfici levigate e lavorate su ogni faccia, eccetto un’estremità più sottile, lasciata deliberatamente grezza. Un segnale inequivocabile: le pietre del drago erano inizialmente posizionate in verticale, infisse nel suolo come autentici pilastri rituali. Il fatto che oggi molte giacciano rovesciate o frammentate deriva da millenni di fenomeni naturali, non dalla loro destinazione originaria.
Le raffigurazioni incise non sono casuali. Alcuni monoliti evocano grandi creature acquatiche, altri richiamano pelli bovine stese, altri ancora combinano entrambe le rappresentazioni. Anche in questo caso, la disposizione segue una logica precisa. Le pietre con forma ittica si concentrano maggiormente alle quote superiori, presso le sorgenti montane. Quelle che evocano pellami animali compaiono più a valle, dove l’acqua veniva convogliata per scopi agricoli. È il riflesso di un’esistenza scandita dalla transumanza stagionale, dalla pastorizia e dalla gestione idrica.
Quando lo sforzo diventa irrilevante, perché il sito è venerato
C’è un ulteriore elemento che sorprende e smentisce ogni interpretazione “utilitaristica”. I vishap non diminuiscono di dimensioni all’aumentare dell’altitudine. Al contrario. Blocchi superiori alle sei tonnellate sono presenti sia nelle aree più raggiungibili sia sulle vette più isolate. Se fossero stati semplici indicatori territoriali o monumenti simbolici, la razionalità avrebbe suggerito strutture più leggere in alta montagna. Ma la razionalità, qui, si arresta di fronte alla devozione.
Questo impegno straordinario ha senso esclusivamente se quei luoghi erano ritenuti sacri. Le fonti presso le cime, dove nasce la neve e si origina l’acqua, possedevano un significato profondamente spirituale. A confermare questa lettura c’è una scoperta recente: sotto un vishap, nei pressi del lago Sevan, sono state rinvenute tombe infantili. Un gesto che testimonia protezione, perpetuazione della vita, un vincolo profondo tra acqua, nascita e collettività.
Precedono Stonehenge e non furono mai abbandonati
Le datazioni situano alcuni vishap tra il 4200 e il 4000 a.C. Sono dunque anteriori a Stonehenge di oltre un millennio, e costituiscono una delle più antiche evidenze note di monumentalità rituale associata all’acqua.
L’aspetto più straordinario è che questo vincolo non si è mai interrotto. Nei secoli seguenti, altre civiltà hanno continuato a riconoscere il valore sacro di questi siti. Alcuni vishap sono stati incisi con scritture urartee, altri con croci e simboli cristiani. Mutavano le religioni, ma non la reverenza per l’acqua e per quei megaliti che la custodivano simbolicamente.
Oggi numerose di queste pietre sono deteriorate o abbattute, e i ricercatori stanno operando per ricostruire il loro ruolo integrando dati archeologici, climatici e idrologici. L’obiettivo è comprendere come l’acqua abbia plasmato non solo il territorio, ma anche le migrazioni, la cooperazione e le credenze delle prime società montane.
In silenzio, da sei millenni, i vishap continuano a trasmetterci una verità elementare e attualissima: senza acqua non esiste vita, e salvaguardarla è sempre stato un gesto sacro.
Fonte: npj Heritage Science