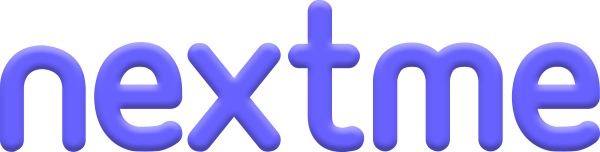Un fenomeno celeste straordinario sta catturando l’interesse degli studiosi del cosmo e degli appassionati in ogni angolo del pianeta. Si tratta della cometa C/2025 K1 (ATLAS), un corpo celeste particolare che si distingue per la sua colorazione dorata anziché presentare le classiche tonalità verdi o azzurre.
Questa insolita caratteristica cromatica deriva, secondo le analisi scientifiche, da una ridotta presenza di elementi carboniosi, quelli che normalmente conferiscono alle comete le loro tinte più diffuse. Tale composizione chimica ne fa un esemplare eccezionale e, per coloro che avranno l’opportunità di ammirarla, un’esperienza visiva memorabile.
Individuata il 24 maggio 2025 attraverso il sistema di monitoraggio ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), questa cometa ha origine dalle zone più remote e gelide del nostro sistema planetario, verosimilmente dalla Nube di Oort, un’immensa riserva di detriti congelati che orbitano ai confini estremi dell’influenza solare.
Orari e posizione per l’osservazione dall’Italia
Attualmente questo corpo celeste è individuabile nel settore orientale della volta celeste, nell’area compresa tra le costellazioni della Vergine e del Leone. Dal territorio italiano è possibile osservarla nelle ore comprese tra le 2:30 e le 5:30, nel periodo che precede il sorgere del sole.
Tuttavia, l’osservazione diretta senza ausili ottici risulta impossibile: la sua luminosità apparente si attesta intorno a una magnitudine di +10, ampiamente al di sotto della soglia percepibile dall’occhio umano (che si limita a circa +6). Per individuarla è indispensabile utilizzare un telescopio oppure un binocolo astronomico. Nel corso di novembre, la cometa modificherà progressivamente la sua posizione celeste, rimanendo comunque in una zona favorevole all’osservazione fino agli ultimi giorni del mese.
Il superamento del punto di massima vicinanza solare e l’avvicinamento terrestre
La C/2025 K1 ha attraversato con successo il perielio, ovvero il momento di massima prossimità al Sole, durante la giornata dell’8 ottobre 2025, quando si è trovata a una distanza minima di 0,33 unità astronomiche (equivalenti a circa 49 milioni di chilometri). Numerosi ricercatori temevano che l’esposizione all’intensa energia solare avrebbe potuto frammentarla, invece la cometa è sopravvissuta intatta, rivelando una coesione strutturale superiore alle previsioni. Attualmente si sta progressivamente allontanando dal Sole mentre si avvicina al nostro pianeta.
Il suo punto di minima distanza dalla Terra si verificherà il 24 novembre 2025, a circa 1,193 unità astronomiche, corrispondenti a 180 milioni di chilometri. Anche in questa circostanza non sarà percepibile senza strumentazione adeguata, ma costituirà l’opportunità ottimale per osservarla o immortalarla fotograficamente mediante telescopi amatoriali.
L’origine della colorazione aurea: un enigma chimico e fotometrico
La tonalità della chioma che avvolge una cometa fornisce preziose indicazioni sulla sua struttura molecolare. Generalmente, la radiazione solare interagisce con sostanze gassose come il carbonio biatomico (C₂) e il monossido di carbonio ionizzato (CO⁺), generando le caratteristiche colorazioni verdi e blu.
La cometa C/2025 K1 (ATLAS) rappresenta un’eccezione perché sostanzialmente priva di questi composti. Le rilevazioni effettuate dal Lowell Observatory evidenziano che la sua chioma presenta concentrazioni di carbonio eccezionalmente basse se confrontate con la quantità di radicali idrossilici (OH). Ne consegue una sfumatura dorata, generata dalla riflessione della luce solare sulle particelle polverose, non modificata dai gas cromogeni che solitamente la alterano.
Solamente due comete conosciute, la Yanaka e la 96P/Machholz 1, mostrano una struttura chimica analoga. Un evento talmente eccezionale da rendere la C/2025 K1 un soggetto di notevole rilevanza per comprendere l’evoluzione chimica del nostro sistema planetario.
Un relitto ghiacciato proveniente dalle profondità cosmiche
I ricercatori ipotizzano che questa cometa abbia origine dalla Nube di Oort, una zona periferica costituita da miliardi di piccoli nuclei ghiacciati che percorrono orbite a distanze immense dal Sole. Questi oggetti vengono considerati residui primordiali del processo di formazione del sistema planetario, mai modificati dal calore stellare o dall’interazione con i pianeti interni.
La C/2025 K1 (ATLAS), pertanto, trasporta con sé dati fondamentali sulla materia primigenia che ha contribuito alla nascita dei pianeti e dei satelliti naturali. Ogni volta che una cometa di questa natura penetra nelle regioni interne del sistema planetario, gli studiosi ottengono l’occasione di esaminare gas e polveri rimasti inalterati per miliardi di anni.
Esistono comete che transitano senza lasciare traccia, e altre che incidono profondamente nella memoria collettiva. La C/2025 K1 rientra in questa seconda categoria. Ha resistito a un incontro ravvicinato con la nostra stella e ha convertito la sua flebile luminosità in un bagliore aureo senza precedenti. Per chi avrà la determinazione di individuarla nella volta notturna, rappresenta un’occasione irripetibile: la chance di contemplare una reliquia vivente delle origini del Sistema Solare, al contempo fragile e incredibilmente resistente.
https://www.facebook.com/FriendsOfNASA/posts/pfbid02PeamQiyGn6FAZgWQiAkb5v2ALtsqaGHQkPwyHzM9pJunXJ4MeBSH8PToDHn7XH37l
Fonte: friendsofnasa