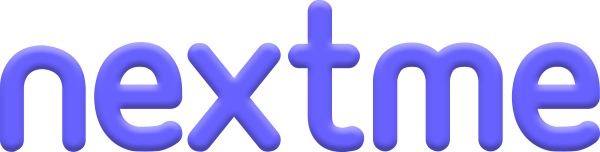Quello che doveva essere un ordinario cantiere per realizzare un serbatoio idrico presso il borgo di Wolkertshofen, nella regione bavarese, si è trasformato in un ritrovamento archeologico inaspettato. Durante gli scavi, a pochi metri di profondità, gli operai hanno portato alla luce una costruzione in pietra dalla forma perfettamente rotonda, con un diametro di dodici metri e realizzata con blocchi lavorati con straordinaria accuratezza.
La struttura circolare, assemblata con pietre levigate e posizionate con estrema cura, presentava anche una piccola piattaforma quadrangolare sul versante meridionale. Probabilmente serviva a sostenere una scultura o un elemento votivo. La sorpresa più grande, però, è emersa durante l’analisi: la struttura era completamente vuota. Nessuna traccia di sepoltura, nessun reperto, nessun frammento ceramico. Solo pietra e vuoto.
I ricercatori del Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, l’istituzione bavarese preposta alla salvaguardia del patrimonio storico, hanno classificato il ritrovamento come “eccezionalmente insolito”. Non soltanto per le proporzioni, ma perché nella regione non esistono precedenti di tombe romane analoghe, come ha dichiarato Mathias Pfeil, responsabile dell’ente:
Non immaginavamo di imbatterci in un monumento funerario di quest’epoca e con queste caratteristiche in questa zona. Rappresentava un luogo di commemorazione e distinzione sociale. Tuttavia, in questo caso, completamente privo di resti.
Una sepoltura simbolica senza defunto?
L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un cenotafio, ovvero una tomba commemorativa eretta per onorare qualcuno la cui sepoltura si trova altrove.
Un atto simbolico, ma significativo: un modo per tramandare il ricordo di una persona, non il suo corpo.
Nell’antichità romana, i tumuli funerari – sepolture coperte da monticelli di terra – erano comuni nell’area mediterranea, ma estremamente rari nella provincia della Rezia, che includeva l’attuale Baviera meridionale, alcune zone della Svizzera e del Tirolo. Questo rende il ritrovamento particolarmente significativo: una costruzione di stampo romano edificata nel cuore della Baviera, lungo un’antica arteria che collegava Nassenfels alla valle dell’Altmühl, nelle immediate vicinanze di una villa rustica, tipica residenza rurale dell’epoca.
Non si trattava quindi di un luogo casuale. Secondo Pfeil, una famiglia romana agiata scelse deliberatamente questa posizione per far costruire un monumento visibile a tutti i viaggiatori che transitavano su quella via: «Un simbolo di memoria e autorità. Un modo per affermare: “la nostra presenza è stata qui”».
Contaminazioni culturali: i Romani potrebbero aver adottato usanze celtiche
Esiste però un elemento ancora più affascinante. In Baviera, i tumuli circolari erano presenti già molto tempo prima dell’arrivo dei Romani, risalendo all’età del Bronzo e del Ferro. Questa evidenza ha spinto gli studiosi a ipotizzare che possa trattarsi di una deliberata ripresa delle consuetudini locali, una sorta di “riconoscimento” verso le tradizioni celtiche preesistenti alla dominazione romana.
Il sito bavarese, infatti, si colloca in un’area di confine tra differenti culture: un territorio di scambi e fusioni, dove pratiche rituali e forme architettoniche si fondevano. Secondo la documentazione ufficiale, in epoca romana alcuni tumuli più antichi venivano riutilizzati o replicati, forse per creare un legame di continuità culturale, o per rendere più accettabile la presenza romana presso le comunità locali.
Un vuoto eloquente
Attualmente, le indagini archeologiche continuano. Gli studiosi auspicano di individuare ulteriori elementi – un dettaglio, una testimonianza, qualsiasi cosa che possa rivelare chi abbia voluto quella costruzione circolare priva di contenuto. Ma, anche qualora non emergessero nuovi dati, il sepolcro di Wolkertshofen rimane un ritrovamento di grande rilevanza.
Perché, come afferma Pfeil:
L’importanza del sito non risiede in ciò che racchiude, ma in ciò che ci comunica.
Talvolta, la storia si manifesta proprio attraverso ciò che manca.
Fonte: blfd.bayern.de