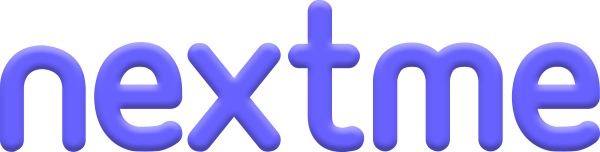Dal momento del suo ingresso nel nostro sistema planetario lo scorso luglio, 3I/ATLAS ha catalizzato l’attenzione della comunità astronomica mondiale. Si tratta di uno di quei visitatori cosmici che provengono dall’esterno, solcano il nostro spazio celeste con apparente disinvoltura e, proprio quando pensiamo di averli compresi, riservano ulteriori rivelazioni. L’ultima novità proviene dal territorio sudafricano, dove il potente radiotelescopio MeerKAT, dotato di un’antenna da 13,5 metri di diametro, ha registrato la primissima evidenza radio collegata a quello che potrebbe essere un nucleo cometario extrasolare.
Nessun bagliore improvviso, nessuna trasmissione enigmatica degna di una sceneggiatura fantascientifica. La rilevazione, concretizzatasi il 24 ottobre 2025 dopo due precedenti tentativi andati a vuoto, appare decisamente più misurata eppure altrettanto affascinante: un fenomeno di assorbimento nelle frequenze radio, una peculiare traccia identificata nell’intervallo tra 1,665 e 1,667 GHz.
Un particolare apparentemente minuto per gli osservatori celesti, ma un elemento cruciale per decifrare l’autentica natura di 3I/ATLAS.
L’impronta degli idrossili e il dibattito sull’identità dell’oggetto
Il merito della scoperta spetta al gruppo di ricerca coordinato dal professor D.J. Pisano dell’ateneo di Città del Capo, coadiuvato da Avi Loeb, figura di spicco nel panorama dell’astrofisica contemporanea e delle ipotesi non convenzionali. Secondo le analisi del team, l’assorbimento documentato da MeerKAT corrisponde alla presenza dei gruppi OH, quei frammenti molecolari che emergono quando molecole d’acqua vengono colpite dalla radiazione stellare.
È proprio in questo frangente che la narrazione diventa particolarmente stimolante, poiché 3I/ATLAS rappresenta un corpo celeste che continua a eludere classificazioni precise. Alcuni ricercatori propendono per identificarlo come un nucleo cometario di origine extrasolare, mentre altri mantengono aperta l’ipotesi di una provenienza più insolita, persino artificiale. Nessuna certezza assoluta, semplicemente un monito a non considerare scontata la natura di ciò che attraversa gli abissi cosmici.
La rilevazione degli idrossili, tuttavia, fornisce un’indicazione molto concreta: depositi di ghiaccio che rispondono all’irraggiamento solare. Una caratteristica decisamente più affine a un corpo cometario che a un manufatto inerte o di composizione metallica.
Grazie a questa osservazione, gli studiosi hanno potuto anche calcolare la temperatura superficiale dell’oggetto: approssimativamente –43 °C. Un freddo intenso che preserva i componenti volatili, destinati probabilmente a sublimazione man mano che l’oggetto riduce la propria distanza dal nostro astro. Nel momento della misurazione si posizionava a 1,38 unità astronomiche dal Sole, una regione dove l’energia termica comincia a manifestare i propri effetti, anche su un viaggiatore proveniente da altri sistemi stellari.
Il profilo che ne deriva descrive un corpo tutt’altro che roccioso e inerte, bensì un aggregato delicato e reattivo alla luce, quasi portasse con sé un carico di sostanze pronte a mutare stato.
L’eco del segnale Wow! riaffiora nella discussione
Esiste un’ulteriore suggestione che accompagna 3I/ATLAS: la sua rotta sembra dirigersi verso la medesima porzione di cielo da cui, nell’estate del 1977, giunse il celebre segnale Wow!, quell’impulso radioelettrico che da quasi mezzo secolo alimenta dibattiti tra scettici e visionari.
Nessuno sta affermando che esista un nesso diretto tra i due eventi, ma l’interrogativo persiste, ostinato, come accade spesso con le domande più stimolanti. La comunità astronomica nutre la speranza che nelle settimane a venire la sonda Juno, in orbita gioviana, possa esplorare bande di frequenza più basse e raccogliere informazioni che MeerKAT non può catturare dalla superficie terrestre.
Al momento disponiamo di questa certezza: 3I/ATLAS ha emesso un segnale, a modo suo. E gli scienziati si preparano ad ascoltarlo nuovamente.
Fonte: astronomerstelegram.org